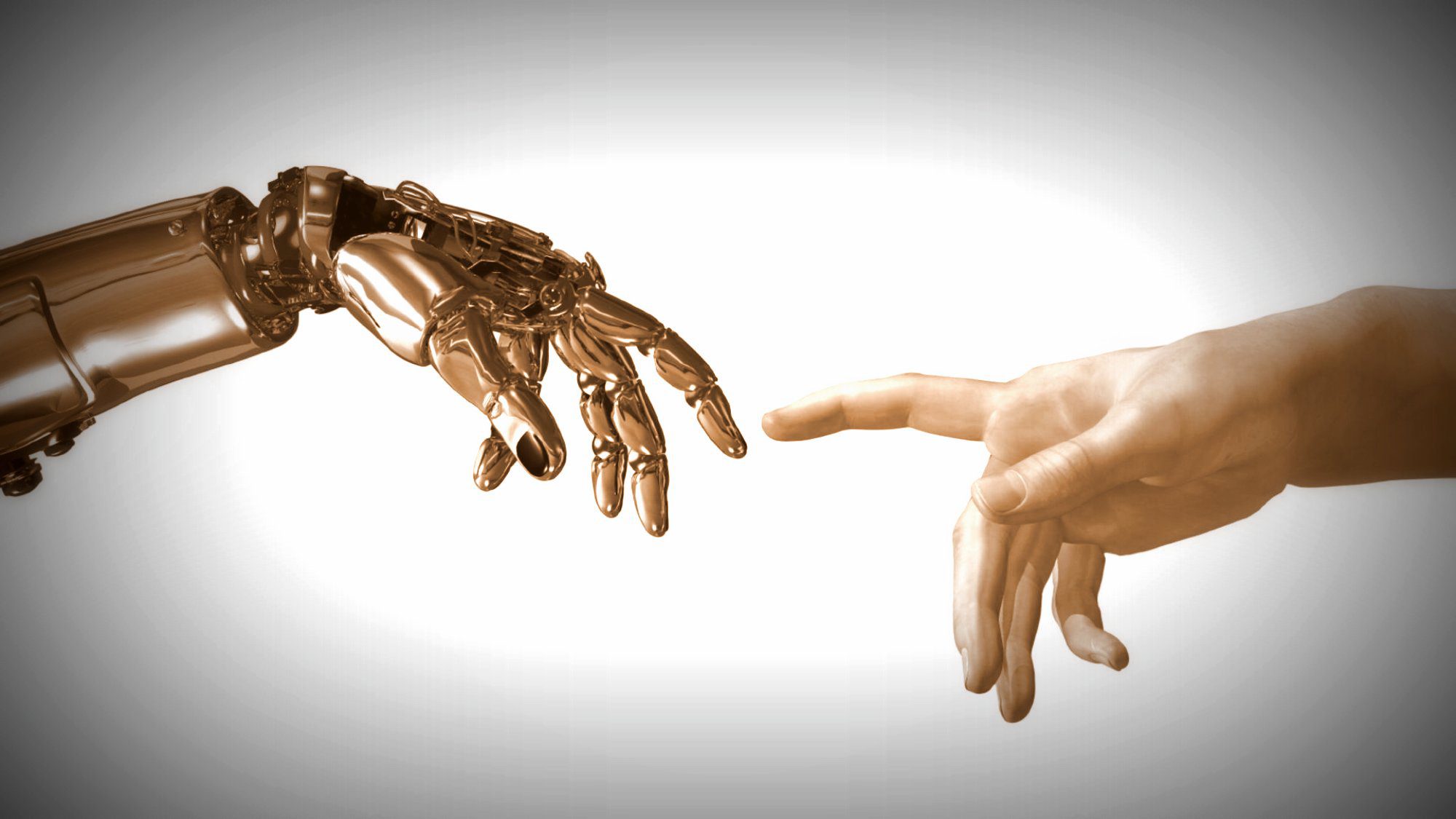A proposito di industria 4.0: “Una rivoluzione non solo tecnologica, ma anche e soprattutto culturale”
di Marco CIANI, Segretario generale Cisl Alessandria-Asti
Riflessioni sui temi protagonisti della tavola rotonda promossa dalla Fim Cisl Alessandria-Asti “La Fim per la sfida delle relazioni industriali 4.0” – Asti, 4 aprile 2018
Seguo con molto interesse le vicende di industria 4.0, e non solo per motivi professionali. Sono sinceramente affascinato da quel che sta accadendo. Da ciò che ho potuto capire, siamo probabilmente solo all’inizio di una rivoluzione che pare destinata a stravolgere il mondo per come lo conosciamo. Una rivoluzione che non è solo tecnologica, ma forse anche e soprattutto culturale.

Il contributo di Marco Ciani, Segretario generale Cisl Alessandria-Asti, intervenuto al dibattito promosso dalla Federazione dei Metalmeccanici Cisl territoriale, alle presenza di Marco Bentivogli, Segretario generale Fim, esperti e numerosi delegati
Come è stato evidenziato, accanto a indubbi benefici in termini di produttività e di riduzione della fatica e dei lavori routinari, si presentano anche rischi di non poco conto per la tenuta dell’occupazione e la sua qualità. Credo che ad oggi sia sostanzialmente impossibile prevedere se in futuro, almeno in quello prossimo, il saldo occupazionale risulterà positivo o negativo. Gli analisi più qualificati sono divisi. Vi sono pareri concordi sulla riduzione dei posti di lavoro. Molto meno sulla quantità di nuova occupazione che si potrà creare a seguito dell’innovazione in corso. Tutti però concordano su un fatto: il mondo del lavoro è destinato a cambiare molto con una velocità vertiginosa, a seguito di tecnologie che vengono definite da Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee nel saggio/manifesto “The second machine age” (tradotto in Italia col titolo “la nuova rivoluzione delle macchine”) di tipo esponenziale e combinatorio
Anche per questo credo sia saggio evitare sia l’opinione secondo la quale non stia accadendo nulla di particolarmente nuovo perché ciò che vediamo sarebbe niente altro che una delle tante fasi dell’innovazione, sia le visioni estreme che sono di due tipi: quelle contrassegnate dal più cupo pessimismo (le macchine ci rubano il lavoro) e quelle orientate ad un ottimismo trionfale che vede nel profondo mutamento in atto solo opportunità. A mio modesto parere sussistono sia potenzialità che rischi, non sappiamo ad oggi in quale mix. Per questo l’atteggiamento più ragionevole non può che essere un sano e prudente realismo informato alla volontà di confrontarsi con l’evoluzione per governarla e non doverla subire.
Ci sono però alcuni aspetti che sembrano condivisi dalla gran parte di chi si occupa di innovazione.
Primo punto è l’impatto della tecnologia. Avviene con una velocità sconosciuta in passato. Lo vediamo dai mutamenti sempre più impressionanti. Io cito spesso l’esempio dello smartphone, che ci è particolarmente familiare, perché ha trasformato un elettrodomestico che serviva per telefonare, e al massimo per trasmettere corti messaggi, in uno strumento complesso all’interno del quale convivono decine di app diverse in costante incremento quali- e quanti-tativo. E soprattutto, cosa ancor più importante, ci tiene costantemente interconnessi.
Se penso ai miei figli, che hanno 8 e 12 anni, per loro il mondo degli smartphone e dei tablet è assolutamente scontato. E infatti li usano in continuazione. Anche troppo. Per noi adulti invece, questo strumento ha traguardato il decennio solo pochi mesi fa, da quando Apple nel 2007 presentò e mise in vendita il primo IPhone. Pensate come in poco più di 2 lustri è cambiato il mondo. Oggi vedete gente in ogni luogo che guarda continuamente lo schermo del proprio cellulare per gli usi più svariati. Secondo i dati della società fondata da Steve Jobs in media lo consultiamo 80 volte al giorno.
Il tema della tecnologia propone anche altre considerazioni. Qualche settimana fa ascoltavo Marco Giovannini, A.D. del Gruppo Guala Closures, una delle maggiori aziende multinazionali non solo dell’alessandrino, spiegare come l’impresa sia costretta ad assumere ingegneri dal Sud Italia non trovandone a sufficienza in zona.

I protagonisti della tavola rotonda: da sinistra Paolo Rebaudengo, esperto di relazioni industriali, Giovanna Damiano, direttore dello stabilimento Epta SpA., Marco Bentivogli, Segretario generale Fim Cisl, Marco Ciani, Segretario generale Cisl Alessandria-Asti, ed Alessandro Rota Porta, consulente del lavoro Il Sole 24 Ore, che ha moderato il dibattito.
Dunque lavorare nell’era dell’impresa 4.0 richiede in molti casi skill (abilità) soprattutto di tipo tecnico che si trovano a fatica nel nostro Paese. È il “digital divide”, ovvero il divario tra le competenze possedute e quelle che servirebbero per svolgere professioni nel mondo digitalizzato. Ma anche abilità relazionali poco diffuse, soprattutto soft skills o competenze trasversali (ad es. nel Collaborative problem solving). Una differenza di preparazione che produce un crescente divario tra le professionalità richieste dal mondo del lavoro e quelle possedute da chi invece il lavoro lo sta cercando.
Dunque, e introduco la seconda considerazione, anche nello scenario più roseo, assisteremo ad un massiccio spostamento di manodopera tra settori diversi della produzione. Se guardo al nostro territorio, mi viene in mente ad esempio alla situazione drammatica del commercio. Pensiamo ad esempio a negozi di elettrodomestici, librerie, agenzie di viaggio, etc. Tutte attività destinate a sparire o quasi, ma come molte altre in un futuro più o meno prossimo, malgrado le iniziative sindacali per scongiurarne gli effetti più devastanti. Serve riconvertire le persone, aiutarle nel passaggio da una professione ad un’altra, da un settore all’altro. In alcuni casi a diventare imprenditori di se stessi. Non è una cosa semplice. Specie per i meno giovani.
Viene richiesto ai lavoratori di riqualificarsi e quindi formazione, flessibilità, voglia e anche possibilità di rimettersi in gioco. Tutti aspetti che si danno spesso per scontati. Ma che invece sono complessi anche perché le persone hanno magari una famiglia che direttamente o indirettamente finisce per essere coinvolta nei processi di riconversione del lavoratore. Creando problemi di bilanciamento non facili tra vita professionale e familiare.
Aggiungerei, a corollario, che le questioni suddette producono degli effetti sociali.
Per la maggior parte dei casi, l’impatto non è positivo. Timore per il proprio futuro occupazionale, senso di inadeguatezza, stress da adattamento, etc. Problemi a volte reali, in altri casi più percepiti che effettivi, ma comunque non trascurabili
Io penso, per venire al tema della nostra discussione odierna, che la sfida delle relazioni industriali 4.0 significhi principalmente come noi decidiamo di affrontare i mutamenti che abbiamo evidenziato.
Che coinvolgono anche i modelli organizzativi aziendali (pensiamo ad esempio allo smart working), il tempo del lavoro (il confine tra lavoro e non lavoro diviene sempre più labile), i contratti. Vorrei citare su questo punto un caso emblematico, poco conosciuto ma interessante, che riguarda il mio datore di lavoro, Intesa Sanpaolo.
Nella più grande banca del paese qualche anno fa è stato sottoscritto da tutte le OO.SS. con l’azienda un contratto sperimentale chiamato “minotauro”, che nasce dall’unione di due contratti: per metà (part/time) lavoro subordinato, per l’altra metà prestazioni a partita IVA. Esempio di un’evoluzione in corso che produce nuovi tentativi di adattamento. Ne seguiranno certamente altri.
Esiste poi un tema legato alla rappresentanza sindacale. Come è noto il sindacato nasce a cavallo tra il ‘700 e l’800 allorché un numero consistente di lavoratori con mansioni simili, vengono organizzati nelle fabbriche secondo strutture fortemente gerarchizzate. Secondo schemi per alcuni versi simili a quelli della gerarchia militare. Tanti livelli, uno subordinato all’altro. L’esatto opposto del mondo produttivo attuale.
È la comunanza di problemi a far nascere la consapevolezza che solo unendosi (non a caso le prime associazioni si chiameranno trade unions, o unioni di mestiere), sarà possibile riequilibrare rapporti di forza impari tra padroni e operai, tra capitale e lavoro, tra borghesia e proletariato per usare un linguaggio marxiano che si svilupperà nel corso dei due secoli alle nostre spalle.

Anche le lavoratrici ed i lavoratori presenti in sala sono stati protagonisti del dibattito incentrato sull’innvovazione tecnologica e nuovi scenari lavorativi
Consentitemi un aneddoto storico che riguarda il settore automobilistico. Henry Ford II e Walter Reuther, che era il capo del sindacato dei lavoratori nel settore auto stavano facendo il giro di una delle nuove fabbriche moderne quando Ford si girò scherzoso verso Reuther dicendo, “Ehi, Walter, come farai a far pagare a questi robot la quota del sindacato?”. E Reuther di rimando, “Ehi, Henry, come farai a far comprare loro le automobili?”.
Fuor di metafora. Il modello sindacale consolidato nel ‘900, pur con mille contraddizioni, dopo essersi esteso in tutti i settori merceologici, ha portato indubbiamente dei risultati importanti e un’elevazione della qualità di vita dei dipendenti, tanto da consentire alla parte più lungimirante di sostituire, con il tempo, la lotta di classe con la contrattazione e la concertazione.
Anche qui però dobbiamo porci una domanda. Il lavoro nuovo che avanza è sempre meno un lavoro massificato. Questa evoluzione è già realtà per la fabbrica intelligente (smart factory), o almeno per una buona parte di essa. Ma secondo gli studi avanzati lo sarà anche per i servizi, se è vero come leggevamo pochi giorni fa sul Sole24Ore che entro 10 anni l’ufficio tradizionale sarà un ricordo.
Ma i cambiamenti ci interrogano anche sul futuro del Sindacato. Sarà ancora possibile in un ambiente di lavoro altamente personalizzato (o forse atomizzato) riuscire a garantire la presenza del sindacato, la sua rappresentanza, la sua valenza di agente contrattuale e regolatore dei conflitti? Onestamente è difficile prevederlo. Ma di certo servirà un sindacato nuovo. Per restare in tema: un sindacato 4.0.
Cosa dobbiamo intendere per Sindacato nuovo?
Io penso innanzitutto ad un Sindacato che non si oppone ai cambiamenti, ma ambisce a governarli. Non è una questione scontata. Viviamo una fase nella quale i mutamenti vengono avvertiti da parti consistenti dell’opinione pubblica, composta in buona parte da lavoratori, come pericolosi. Soprattutto per la propria stabilità professionale. Per le condizioni di vita proprie e della propria famiglia.
E queste pulsioni si riverberano anche nel voto. La tentazione di chiedere alla politica di tornare a logiche protezioniste e sovraniste lambisce gli elettorati di mezzo mondo. Pensiamo alle recenti consultazioni italiane. O al trionfo, contro ogni pronostico, di un Trump che vince col consenso determinante di quei lavoratori che vogliono ritornare alle barriere doganali e ai dazi, come quelli sull’acciaio e sull’alluminio dei quali si discute in questi giorni.
Può un’organizzazione come la CISL e con essa la FIM mettersi su questa china? Io penso di no. E non solo perché siamo un paese che fa export per 450 miliardi di euro, in buona parte grazie alla sua industria (siamo la seconda manifattura d’Europa dopo la Germania). Mentre importiamo “solo” 400 miliardi, in buona parte materie prime. Anche in riferimento alle province di Alessandria e Asti, il saldo dell’export è molto positivo.
Ma soprattutto perché immaginare, dopo un generazione che ha visto trionfare la globalizzazione, di poter riportare le lancette indietro di 3 o 4 decenni, senza che ciò determini esiti catastrofici è follia. Noi potremmo forse, non immagino a quale prezzo, tornare all’Italia della lira e delle dogane. Ma questo non riporta in vita Breznev e il blocco socialista, né la Cina degli aratri di legno. Il primo punto dovrebbe pertanto essere questo. Dobbiamo essere un sindacato che accetta la sfida della globalizzazione. Con le sue complessità. Ma che nel contempo vuole governarla e non subirla.
Un secondo punto sta nelle questioni che abbiamo poc’anzi sfiorato. Pensiamo al tema enorme della formazione, riconversione, riqualificazione. Il governo del cambiamento, la possibilità di stare al passo con i tempi mantenendoci alla testa dei paesi evoluti richiede investimenti enormi, non solo in infrastrutture fisiche, come i macchinari dell’impresa 4.0, o immateriali, ovvero tutte quelle legate alla gestione dei dati, enormi quantità di dati che devono essere processati in pochissimo tempo. Richiede soprattutto grandi investimenti in conoscenza. Il lavoro, la qualità di vita professionale, i livelli retributivi saranno sempre più collegati in futuro all’effettiva competenza. Per questo in molti settori, a cominciare da quello metalmeccanico, e qui so che la FIM ha giocato un ruolo fondamentale, la formazione è stata messa al centro dell’attenzione. Si tratta del più importante investimento sulle persone che si possa immaginare. La loro polizza assicurativa per il futuro.
Ma, credo di poter dire altrettanto hanno fatto CGIL, CISL, UIL assieme a Confindustria, con l’ultimo accordo interconfederale sulle relazioni industriali e il modello contrattuale, all’interno del quale il primo obiettivo comune è proprio condividere una strategia di sviluppo basta su formazione, ricerca, innovazione.
L’introduzione del nuovo accordo mi consente di agganciare un’altra suggestione, che vorrei condividere. E cioè la certezza del quadro di riferimento e la partecipazione dei lavoratori alla governance dell’impresa.
Perché l’intesa è strategica? Perché se in uno scenario che presenta caratteristiche di forte volatilità, incertezza, complessità e ambiguità (quello che gli americani chiamano mondo VUCA) noi non introduciamo qualche regola chiara, pur nella sua adattabilità, per fornire certezze ai lavoratori su trattamenti retributivi, welfare, livelli contrattuali, se non ci impegniamo per stabilire assieme dove va il modello, e di conseguenza dove vanno loro, il rischio che il sistema delle imprese italiane diventi altamente instabile è quasi una certezza.
Ma è un sistema di questo tipo quello che vogliamo? Possiamo permetterci un mondo produttivo non governato, in preda ai capricci del mercato e in balia di una rivoluzione tecnologica e culturale non gestita in modo collaborativo? La risposta per me è scontata ed è no.
Il sistema economico va dunque diretto, anche con accordi che lo consolidino potenziandone le opportunità. In un momento, si badi bene, dove è piuttosto difficile attendersi grandi contributi dalla politica. E non è un caso che l’accordo sia stato sottoscritto a pochi giorni dal voto per il rinnovo del parlamento. Evidentemente si ritiene, a mio avviso per ragioni più che fondate, che è meglio se su questi aspetti le parti sociali riescono ad accordarsi senza la politica. La politica ha fatto cose importanti grazie al piano nazionale Industria 4.0. Temo però, se mi consentite una battuta alla Reagan (che fu anche un sindacalista), che nell’attuale frangente la politica non sia la soluzione. Quanto piuttosto il problema. Ovviamente spero di sbagliarmi ed essere smentito.
Non meno importante è il punto sulla partecipazione. E’ un tema difficile, lo sappiamo. Mi potrò sbagliare ma credo che valorizzare la partecipazione organizzativa dei lavoratori sarà sempre di più una condizione indispensabile per sviluppare la competitività delle imprese e il miglioramento del lavoro. I modelli sono diversi. Credo che sia il sindacato che le aziende debbano su questo aspetto mantenere un atteggiamento aperto di dialogo, ma poi provare a darsi qualche obiettivo concreto, anche graduale di coinvolgimento nella governance aziendale.
In fin dei conti, almeno in Europa, le economie più vivaci e con le imprese più forti sono anche quelle dove i lavoratori e le loro rappresentanze sono parte attiva e proattiva dei processi industriali, anche al di là della loro funzione di regolatori. Si tratta di una sfida da raccogliere.
Così abbiamo anche introdotto il tema dell’Europa, sul quale vorrei chiudere. Se i fenomeni di cui abbiamo parlato finora riguardano tutti, se le imprese operano su scala globale, se il mondo è interconnesso, se i nostri problemi dipendono sempre di più anche da cosa fanno gli altri, ne consegue che anche il Sindacato deve pensare di più su scala internazionale, almeno a partire dall’Europa.
Qui siamo purtroppo indietro. A livello di CES dobbiamo certamente sviluppare integrazione e capacità di essere incisivi nelle sedi comunitarie. L’ottimo lavoro che Luca Visentini, il Segretario Generale del sindacato europeo, sta svolgendo va sostenuto. La CISL è in prima fila nell’appoggiare questa battaglia, anche se le difficoltà sono tante. Dipende anche qua da cosa vogliamo fare da grandi. Abbiamo l’opportunità di contribuire a un processo di integrazione che deve poter proseguire malgrado le tante complessità, a pena di una catastrofe storica, o di starne fuori rinunciando a essere protagonisti. A mio avviso non possiamo che scegliere la prima strada. La CISL nasce europeista e continuerà a muoversi dentro quell’orizzonte.
Questo però richiede anche al sindacato di avviare una riflessione su se stesso. Siamo abbastanza bravi quando si tratta di spiegare agli altri come cambiare. Molto meno a farlo a casa nostra. Il mondo, e con esso il lavoro, la vita stessa delle persone e il modo con il quale tutti gli elementi del contesto si relazionano si stanno evolvendo sempre più in fretta. Chi troppo si attarda è destinato ad essere relegato nel passato. Per questo io penso, e concludo, che la prima sfida per affrontare il mondo 4.0 è cambiare noi stessi. Nei tempi giusti. Tenendo fede ai principi di giustizia e solidarietà che costituiscono il nostro patrimonio, ma adeguando i nostri modelli e gli schemi mentali. Il compito, invero, più difficile. Ma oggi anche il più necessario.
Vale dunque la pena fare nostra la prospettiva di Andrew McAfee: “I fatti puri e semplici dell’età della macchina stanno diventando chiari e ho piena fiducia nel fatto che li useremo per delineare il giusto percorso”.
Categoria: Attualità, Industria, Iniziative, Mercato del Lavoro, Territorio